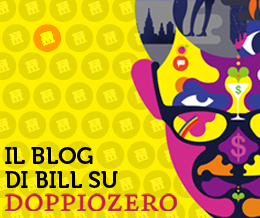Questa rivista è dedicata a William "Bill" Bernbach.
La sua visione della pubblicità - civile, mai banale, basata sulla verità - appare sempre più attuale.
Benvenuti e buona visione.
Cinema e pubblicità hanno una lunga storia in comune. Non sempre d’amore. Sull’argomento Giuseppe Mazza ha tenuto una lunga lezione allo IULM. Questo è un estratto. Con un sacco di video interessanti da guardare.
Iniziamo dal grande rimosso. Gli storici del cinema definiscono L’uscita dalla Fabbrica Lumière, un breve filmato del 1985, la prima autentica messa in scena pensata per una proiezione pubblica ripetuta, dunque anche il primo vero film della storia. Ma di questo “primo film” non si dice che servì ai Lumiere per presentarsi come marchio. Prima ancora che autori di cinema, i Lumiere erano infatti degli imprenditori. La loro attività, che abitualmente consisteva nella produzione industriale di lastre per la fotografia, stava allora sperimentandosi nel nuovo business del cinematografo.
Questo spiega come mai il titolo non sia semplicemente “L’uscita dalla fabbrica”. Il motivo è semplice: il filmato venne realizzato per “firmare” la prima uscita pubblica dell’invenzione, e battere sul tempo la concorrenza tra gli altri di George Eastman (l’inventore della pellicola) e Thomas Edison (che nel 1894 aveva inventato il cinescopio, un tubo che consentiva la visione di immagini in movimento). Il set non è che la fabbrica Lumiere. Gli attori, gli operai della fabbrica. Insomma: la parola “Lumiere” figura nel titolo proprio in quanto brand, come diremmo oggi, e il primo film consiste in un’autopubblicità, nella creazione cioè di un girato che dimostri al mondo la loro primogenitura, affermando il loro marchio e risolvendo una vera e propria guerra industriale.
L’uscita dalla Fabbrica Lumière, 1895
Un’azione pubblicitaria. I fratelli Lumiere come “Ad Men” del loro stesso prodotto: ne documentano il funzionamento, filmano i suoi effetti mettendolo in scena e poi lo proiettano. Un marchio che si promuove.
Il nesso tra cinema e pubblicità è dunque strettissimo dall’inizio. Quanto però regolarmente evitato dalle storie del cinema. Il solo “Dizionario della pubblicità” della Zanichelli (1994), firmato da Alberto Abruzzese e Fausto Colombo, ragiona su questo aspetto del filmato dei Lumiere affermando: “la grande avventura del cinema è nata all’insegna della pubblicità”.
È ovviamente inestricabile il rapporto tra cinema e merce. Senza addentrarci, basti ciò che Alfred Zukor, il famoso produttore cinematografico fondatore della Paramount Pictures, disse a un amico: “Voi credete che non si possa guadagnare che sullo zucchero e la seta? Certo, la gente vuole mangiare delle cose buone ed essere ben vestita, ma gli uomini non sono bestie. (…) Gli uomini vogliono anche sognare. Hanno bisogno dei loro sogni. Ebbene noi fabbricheremo dei sogni, dei sogni in serie, dei sogni divertenti che costano poco. (…) Si può trarre da ciò un profitto fantastico” (da “Identità, miti e modelli temporali”, Il cinema americano, Einaudi).
Il fatto è però che quella tra cinema e merce è una vicinanza scomoda. Soprattutto dove, come in Europa, l’arte continua a essere percepita come distante dalla cultura materiale, proiettata in una pura idealizzazione.
Per iniziare a ricucire le fila di questa relazione, esploriamo un argomento poco visitato dalla critica: il cinema sulla pubblicità, ovvero l’advertising come argomento narrativo. Un relazione apparentemente invisibile, spesso ignorata persino nelle sinossi delle guide, ma che attraversa invece la totalità della storia del cinema, dal muto alla Pixar, dalla voga recente dei vampiri al western tradizionale, e perché no anche alle serie tv, con una vastità forse impossibile da censire fino in fondo.
Il pubblicitario
Guardiamo per esempio alla figura del pubblicitario nel cinema. Com’è stato raccontato? Cominciamo guardando al cinema americano. Qui il personaggio del pubblicitario si trasforma attraverso i decenni coincidendo con i mutamenti reali dell’americano medio, con la sua biografia sociale. Una storia vera, a tutti gli effetti.
Per tutti i primi decenni del Novecento al cinema, infatti, il pubblicitario è il personaggio metropolitano che più si identifica con il sogno americano. Una figura perfettamente integrata, solare, piena di vita. La pubblicità, poi, è il mezzo per il successo, lo strumento ideale per emergere dalla folla. E’ così in “The Crowd” di King Vidor, del 1928, (in Italia “La folla”) uno dei grandi capolavori del muto, nel quale le ambizioni di emancipazione economica sono affidate al tentativo di inventare uno slogan vincente in uno dei tanti concorsi dell’epoca. In questa scena vediamo il protagonista arrivare a New York pieno di speranze. Poco dopo lo ritroviamo già inglobato nella società di massa, intento sì a coltivare i suoi spunti creativi, ma durante l’orario di lavoro, di nascosto.
La folla, di King Vidor, 1928
Vent’anni dopo, in The Hucksters di Jack Conway del 1947, (tratto da un romanzo di successo in verità non tenero con l’ambiente della pubblicità) il pubblicitario è interpretato nientemeno che da Clark Gable, come dire uno dei massimi eroi positivi. È appena tornato dalla guerra, ha visto l’inferno e prova un intenso desiderio di vivere una vita più sincera.
In questa scena si assiste a una riunione con un tirannico cliente. Tutti i partecipanti, un’accolita di yes man, approvano la campagna per “Beauty Soap” preferita dal padrone, che raffigura una modella vestita come se fosse una “donna di piacere”. Tutti tranne Gable, che insorge propugnando – pur senza le parole di Bernbach – l’esigenza di una pubblicità più autentica e umana: “il sapone è un prodotto pulito e non ha niente a che fare con il boudoir”. Purtroppo, il cliente appare disinteressato a certe sfumature. Per lui ciò che conta è martellare il proprio target, come spiega eloquentemente battendo il pugno sul tavolo e urlando a ripetizione il nome del suo prodotto. Eppure, Gable riuscirà a convincerlo: alla fine della riunione il cliente arriverà addirittura a togliersi il cappello in segno di rispetto. E’ il caso di dire che è una storia hollywoodiana…
The Hucksters, di Jack Conway, 1947
Una dimostrazione di quanto il pubblicitario possa incarnare il più alto grado di integrazione nell’american way of life è dato anche dall’esempio successivo. I led three lives di H.A.Philbrick, un telefilm andato in onda negli Stati Uniti tra il 1953 e il 1956, racconta una storia vera quanto incredibile. Quella di un pubblicitario che è al tempo stesso anche un agente della Cia e un infiltrato tra i comunisti americani, vivendo per l’appunto tre vite parallele. A chi, se non a lui, rappresentante per eccellenza del sistema produttivo, spetta il compito di contrastare i nemici giurati del capitalismo? Il pubblicitario da un lato produce il consumo, dall’altro lo difende.
Una figura irripetibile, quella di Philbrick, perché strettamente legata alla stagione del maccartismo. In un continuo gioco di specchi tra verità e finzione, il pubblicitario si mobilita perché americano integro e tutto d’un pezzo, ma al tempo stesso riesce a infiltrarsi perché padroneggia l’arte della finzione e della retorica. La scena che vediamo descrive proprio la costruzione del messaggio retorico. Il pubblicitario infiltrato ha scritto un testo contro il capitalismo per dei volantini, ma i suoi concept sembrano fin troppo espliciti ai seguaci dell’Unione Sovietica, che li preferirebbero più melliflui. Propaganda contro “soft sell”.
I led three lives, 1953/56
Se il pubblicitario americano è un personaggio reale e, al netto della sua fede e delle sue crisi, risulta sempre concretamente partecipe delle mutazioni del paese, in Europa intanto il personaggio si precisa in modo completamente diverso.
Soprattutto in Italia, dove cultura cattolica e marxista convergono verso un’idea poco nobile del denaro su cui tanto è stato scritto (sterco del demonio, e via dicendo), il pubblicitario non è l’immagine di qualcosa di autentico. Semmai un elemento astratto, il terreno di una battaglia culturale. Gli autori di cinema lo raccontano come il luogo simbolico di una decadenza in atto. Non è un mestiere, è un emblema. Più con lui avanza la pubblicità americana e più la nostra purezza è compromessa, più si espandono i consumi e più la nostra civiltà è in pericolo.
Ed ecco nel nostro cinema i tanti personaggi di intellettuale piegati dal capitale, assoldati da rozzi industrialotti. Persino un autore come Fellini, difficilmente assimilabile alle due principali culture dell’epoca sopracitate, propone lo stesso schema. In “La Dolce Vita” (1960) Mastroianni giunge a Roma con ambizioni letterarie per poi svilirsi sempre più fino a diventare, nelle ultime sequenze del film, agente pubblicitario per divi da strapazzo. In “La vita agra” di Carlo Lizzani, quattro anni dopo, Tognazzi arriva a Milano con intenti rivoluzionari ma diventa un pubblicitario dell’azienda che voleva far esplodere. E si potrebbe continuare.
Con il prossimo filmato siamo in pieno rigetto europeo. Si tratta di una scena da La notte, di Michelangelo Antonioni, del 1961. Mastroianni è lo scrittore Pontano, un autore di successo ma economicamente legato alle fortune della ricca moglie. La festa in casa dell’industriale Ghilimberti sta per concludersi, siamo ai saluti. L’industriale invita Mastroianni in una saletta riservata e gli propone di entrare nella sua azienda: ha bisogno di qualcuno che scriva dei testi capaci di raccontare degnamente la sua attività imprenditoriale. A occhio e croce, pare gli sta chiedendo delle brochure di lusso.
La notte, di Michelangelo Antonioni, 1961 (dal minuto 3:00)
Mastroianni ascolta la proposta con disgusto evidente. E il suo punto di vista coincide con quello del regista, che racconta l’incontro tra i due come un momento insultante per l’integrità artistica dello scrittore. Torna utile l’osservazione di G.P.Brunetta sul personaggio dell’industriale nel cinema di quegli anni: “Pur onnipresenti nel cinema degli anni sessanta gli industriali non verranno mai o quasi mai rappresentati in chiave positiva. Anche sommandoli tutti non si riesce a capire come possano essere proprio loro, questi personaggi volgari, semianalfabeti, ridicoli, gli artefici della ripresa della macchina economica, come abbiano saputo rendere competitive sul piano internazionale decine di industrie e portato in meno di quindici anni una nazione distrutta a ridosso per produttività e reddito delle maggiori nazioni industriali. In questo atteggiamento omogeneo, la cultura cattolica e marxista dei registi italiani si sposa, opponendosi a quella del protestantesimo per cui il denaro non è mai farina demoniaca” (da “Cent’anni di cinema italiano” di G.P.Brunetta, Laterza, 1995).
Intanto, ancora tre anni dopo, negli Stati Uniti si mantiene intatto lo smalto del pubblicitario come americano iper-medio. Clamorosa dimostrazione è “Bewitched” il telefilm noto in Italia come “Vita da strega”. Il plot della serie, come si sa, consiste nella decisione di una graziosa fattucchiera: basta magie, d’ora in poi voglio vivere la più normale delle vite, stare in casa, cucinare frittelle, curare i figli e aspettare il marito. E cosa fa il più normale dei mariti americani negli anni sessanta? Naturalmente, il pubblicitario. In questo episodio, (“Help, help, don’t save me”, in Italia intitolato “Ispirazione magica”) è addirittura lei a suggerire gli slogan al marito a corto di ispirazione.
Vita da Strega, season 1 ep.5, 1964 (dal minuto 2:19 – i layout)
(dal minuto 3:10 – la soluzione)
La strega Samantha continua in verità a ricorrere alle sue arti magiche. E può essere dal nostro punto di vista curioso che, cercando la vita più media, abbia scelto un uomo il quale invece vive di qualcosa di irrazionale, immateriale: l’ispirazione, la creatività. Si tratta però di uno dei racconti più fedeli di una percezione tutta anni ‘60: l’advertising è la magia di ogni giorno, la gioiosa e imprevedibile fabbrica che fa girare il mondo nella giusta direzione. E’ ciò che riempie il frigo e fa sorridere la gente.
Con il prossimo film torniamo in Europa. Siamo in Inghilterra, nel 1967, in piena swinging London. Il clima culturale è molto differente. Il film (“’ll Never Forget What’s is Name”, dell’inglese Michael Winner, incredibilmente tradotto da noi “Il complesso del sesso”) comincia con una dichiarazione di guerra. Vediamo un “advertising executive”, interpretato da Oliver Reed, avviarsi come ogni mattina verso il suo ufficio ma portando con sé qualcosa di particolare: una grossa ascia. Con l’arma in spalla entra nel palazzo, supera la reception, viaggia in ascensore e finalmente arriva davanti alla sua scrivania, colpendola rabbiosamente fino a ridurla in mille pezzi.
Il complesso del sesso, di Michael Winner, 1967
http://youtu.be/3VyZfVuFUPI
Il film è appunto la storia di un uomo disgustato dal suo stesso successo, dal quale cerca in ogni modo di fuggire. Risulta già evidente che per gli autori di cinema mettere in discussione il sistema capitalistico si traduce narrativamente nel mettere in crisi proprio il pubblicitario, ossia il personaggio che ne è stato fino ad allora simbolo gioioso. Da questo momento il pubblicitario diventa dunque l’epicentro di una condizione sempre più difficile.
Ci troviamo insomma già in piena crisi dell’io-americano. In questo caso, il dubbio nell’integrità del sistema è affidato al volto di Kirk Douglas, che ne interpretò il vitalismo in tanti ruoli del cinema classico e può quindi con maggiore spessore esprimerne la crisi. In The arrangement del 1969 (in Italia “Il compromesso”), di Elia Kazan, l’attore interpreta un pubblicitario di grande successo che un giorno, saturo, tenta il suicidio. Sopravvissuto, tenta un rientro in agenzia, e qui assistiamo proprio a questa scena, all’inizio con inquadratura in soggettiva. Ben presto però la crisi investirà la sua intera esistenza.
Il compromesso, di Elia Kazan, 1969
Infine, con un salto in avanti di dieci anni, ritroviamo un tipo di pubblicitario definitivamente trasformato. E’ il mondo a cambiargli intorno, a rifiutarlo, a metterlo in discussione. E’ diventato un personaggio fragile, balbettante, incapace di tenere insieme la propria vita. La sua donna non ha più gli stessi sogni casalinghi della strega Samantha. Parliamo di Dustin Hoffman in Kramer contro Kramer, del 1979. Film sul divorzio, sulla famiglia americana del tempo, certamente, ma anche sul complicato rapporto tra lavoro e privato, tra ambizioni e sentimenti. Qui vediamo una delle scene iniziali, che si pone come esplicito sovvertimento della tipica narrazione dei mad men: il pubblicitario rientra sì a casa, ma stavolta la moglie gli comunica di volerlo lasciare. Purtroppo, egli è così infervorato dai successi lavorativi da costringere sua moglie a dirglielo per ben tre volte, prima di attirarne l’attenzione.
Kramer contro Kramer, di R.Benton, 1979
Il mestiere del pubblicitario risulta adesso drammaturgicamente perfetto. Fatto di scadenze, non smette di spingere in direzione opposta alla vita vera. L’uomo di Madison Avenue è una bomba, nella famiglia moderna. Totalmente inconciliabile. Il film è uno scontro di “timing”. Da chi correre? Dal figlio con la febbre alta o dal cliente in riunione? Ciò che prima appariva perfettamente armonico, sospeso in un incanto fatato, “Bewitched” come diceva il telefilm, ora risulta insostenibile. L’incanto si è rotto. E questa percezione, che vede nel pubblicitario un mestiere che si è “ammalato”, è destinata a continuare, sebbene con interessanti eccezioni, fino ai primi anni duemila. L’approfondimento però priverebbe questa carrellata della sua caratteristica programmatica, che è la velocità.
Chiudiamo quindi con un omaggio alla pervasività del pubblicitario nell’intera storia del cinema. Persino nel cinema d’animazione. Ecco un estratto da The Muppets take Manhattan, del 1984. Kermit la rana ha perso la memoria e vaga per la città finché non entra in contatto con un gruppo di creativi pubblicitari che lo attraggono nel loro brainstorming. C’è da inventarsi un nuovo claim per “Ocean Breeze”, e l’eroe dei Muppets ha qualche dritta per loro: potrebbero anche limitarsi a spiegare a cosa serve il prodotto.
I Muppets alla conquista di Broadway, di Frank Oz, 1984