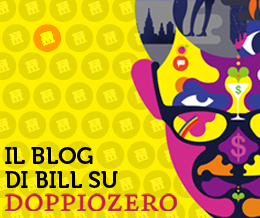Questa rivista è dedicata a William "Bill" Bernbach.
La sua visione della pubblicità - civile, mai banale, basata sulla verità - appare sempre più attuale.
Benvenuti e buona visione.
Bill 15 dedica la sua cover a un grande del design, il leggendario Ken Garland, che cominciò a dire cose non banali sul linguaggio delle merci nel 1963. E non ha ancora smesso. Raccontato da Cosimo BIzzarri.
Ken Garland mi ha fregato in un giorno di primavera del 2012, a Barcellona. Eravamo dalle parti di Calle Laietana, seduti in un’ampia sala dell’agenzia di pubblicità Villar Rosas, che aveva invitato me e lo studio grafico veneziano Tankboys a presentare un progetto a cui lavoravamo da anni. Si chiamava – si chiama ancora – Manifesto e raccoglieva i manifesti programmatici di una ventina di designer e professionisti della comunicazione.
Garland era uno di loro. Un mese prima della mostra, gli avevo scritto un’email chiedendogli se fosse interessato a unirsi a noi a Barcellona per parlare del suo manifesto First Things First. La sua risposta non aveva tardato ad arrivare. In squisito stile britannico, mi aveva fatto sapere che sarebbe stato ‘delighted’, deliziato di unirsi a noi, anche perché, lo ammise candidamente, un biglietto aereo gratis per Barcellona non si poteva rifiutare.
Aggiunse che non c’era bisogno che andassimo all’aeroporto, così aspettammo il suo autobus in Plaza Catalunya. Dal predellino scese un minuto signore di 82 anni: gli occhi azzurri e arzilli, calcata in testa un copricapo beduino che i turisti europei portano a casa dalle vacanze nel Maghreb. “Ne ho sei o sette di berretti così”, ci disse, “La gente mi riconosce per il cappello. Se vado in giro senza, nessuno sa chi sono”.
Difficile credergli. Garland è uno dei designer più influenti della sua generazione: dal 1956 al 1962 ha lavorato come editor di Design magazine, poi ha fondato Ken Garland & Associates, uno degli studi più longevi della scena del design britannico. Ha anche insegnato nelle più prestigiose scuole inglesi di grafica, scritto saggi e libri sul design, progettato libri e giochi per bambini e creato con sua moglie Pudkin Books, una casa editrice che pubblica libri fotografici su oggetti piccoli, apparentemente insignificanti, come sassolini, idranti e foglie cadute.
Parte della sua fama deriva proprio da First Things First, un manifesto che scrisse nel 1963 durante un incontro nel quale si chiedeva a lui e altri quattrocento designer presenti di iscriversi alla SIA (Society of Industrial Artists): “Non volevo appartenere a nulla che non fosse il Labour o un movimento di protesta. Ero seduto nell’ultima fila che pensavo: ‘E adesso come mi tiro fuori da qui?’ Invece di uscire mi sono messo a scrivere quello di cui si sarebbe dovuto parlare secondo me. Quando il moderatore chiese se qualcuno aveva qualcosa da dire, mi alzai e cominciai a declamare il manifesto. All’inizio la gente era perplessa, poi capì e cominciò a scaldarsi. Io ero imbarazzato. L’avevo scritto di getto, senza pensarci troppo sopra”.
First Things First, locuzione inglese solitamente tradotta con ‘prima di tutto’ o ‘tanto per cominciare’, è un testo di 324 parole in cui Garland si scaglia contro la riduzione del mestiere del designer al ruolo di pubblicitario per conto terzi e ammonisce i suoi colleghi che “il nostro ruolo non può essere separato dal contesto sociale in cui operiamo e dagli obiettivi che serviamo”. Garland elenca una serie di prodotti – tra cui cibo per gatti, dentifricio a strisce e lozione dopobarba – la cui promozione risucchia gran parte del tempo e delle energie dei designer. E propone un “rovesciamento delle priorità” in cui ci s’impegni invece a migliorare la vita delle comunità e a promuovere una più grande consapevolezza del mondo, attraverso la progettazione di segnaletica stradale, libri, film e altri prodotti informativi e culturali.
Il manifesto fu controfirmato da ventuno grafici, fotografi e studenti e pubblicato nel 1964 su The Guardian, diventando in breve una pietra miliare per tutti i giovani che, negli anni chiave dei movimenti per i diritti civili, auspicavano che il progetto grafico e la comunicazione in generale potessero contribuire al cambiamento in corso. La fama di First Things First crebbe nel corso del tempo, corroborata dall’esempio sul campo del suo autore.
Già nel 1961, Garland aveva disegnato una campagna per il disarmo nucleare destinata a essere affissa nelle stazioni della metropolitana di Londra. Era un poster con tipografia nera e la parola resistance che spiccava in rosso su campo bianco. Quando il direttivo della metropolitana di Londra reputò inadatto l’uso del termine ‘resistenza’, Garland lo tolse, poi convinse alcuni amici a tornare nelle stazioni, di notte, per riattaccarlo in forma di adesivo. Nessuno se ne accorse.
Quello del disarmo era un tema intimamente legato alla biografia di Garland. Nel 1948, a 18 anni, partì soldato per la Germania appena liberata. Sognava di sparare e tirare bombe, invece da autista finì per girare il paese in lungo e in largo, facendo presto conoscenza con la stupidità della vita militare e con la distruzione e la disperazione causate dalla guerra. Stanco e incazzato, decise di tornare a Londra per finire i suoi studi di grafica alla Central School of Arts and Crafts. Paradossalmente, fu proprio l’esercito a concedergli una borsa di studio. Tra i suoi compagni di corso c’erano Alan Fletcher e Colin Forbes, che avrebbero poi fondato Pentagram, lo studio di grafica più famoso del mondo.
Dopo la pubblicazione di First Things First, Garland continuò ad accompagnare il lavoro di designer con l’impegno politico e un comportamento schietto, sopra le righe e poco incline ai compromessi. Nel 1965, nel corso di una conferenza presso l’Istituto di Arte Contemporanea di Londra, sparò con una pistola giocattolo per dimostrare come certe tecniche per catturare l’attenzione fossero irresistibili. Nel 1967, dopo essersi dimesso dal ruolo di governatore del college artistico di Hornsey per dissensi con la direzione, si unì agli studenti in un sit-in di protesta contro la direzione stessa. Il critico di design Steven Heller ha scritto di lui: “Conoscevo Garland per il suo lavoro contro la guerra e il nucleare. E come la quintessenza dell’agitatore: l’ho ammirato più in questa veste che in quella del grafico moderno di metà secolo e di statura internazionale, cosa che senza dubbio era”.
Sempre nel 1967, durante una conferenza a New York intitolata Design for Survival, design per la sopravvivenza, Garland intervenne elencando quattro passi fondamentali da compiere perché il design potesse sopravvivere e le società potessero prosperare. Il principale era “fare uno sforzo per identificare, e identificarci, con i nostri veri clienti: il pubblico. Non saranno quelli che ci pagano, né quelli che ci danno diplomi e lauree, ma devono essere i destinatari finali dei risultati del nostro lavoro. Sono loro che contano veramente”.
Nel corso degli anni, continuò a realizzare campagne per il disarmo nucleare, rigorosamente gratis, e a lavorare per clienti in linea con la sua visione etica e politica, come Paramount Picture, il teatro Barbican, il Labour Party e il Ministero della Tecnologia britannici. “Non puoi progettare bene per prodotti spazzatura”, ha detto, “Per definizione, se accetti la spazzatura finirai per fare spazzatura. Fine della storia. È uno spreco di tempo”.
Quando il designer statunitense Paul Rand fece il suo nome come referente per la grafica di IBM nel Regno Unito, Garland accettò di incontrare i vertici dell’azienda solo a patto che prima leggessero l’introduzione al suo libro Ken Garland & Associates: Twenty Years of Work and Play. Nel testo Garland diceva chiaramente che non gli era mai piaciuto lavorare con le multinazionali e che le poche volte che l’aveva fatto i risultati erano stati insoddisfacenti. L’amministratore di IBM gli rispose ringraziandolo e ammettendo che quell’incontro sarebbe stato inutile.
D’altronde Garland non vede di buon occhio le corporate identity, che ha sempre considerato pigre e noiose, né l’idea di impiantare una marca nella testa dei consumatori. Nel 1993, in un articolo sulla rivista Eye, pose il problema dell’inquinamento visivo, l’eccesso di elementi grafici superflui come loghi e cartelloni pubblicitari negli spazi pubblici. Propose come soluzione che da un lato fosse la cittadinanza a chiederne l’eliminazione e dall’altro i grafici a garantire che non ne sarebbero stati creati di nuovi: “Non siamo stati formati per farlo, ma se vogliamo veder riconosciuto il nostro status professionale, allora dobbiamo imparare a moderarci e persuadere i nostri clienti a fare lo stesso […] E se la nostra responsabilità verso il pubblico entrerà in conflitto con i desideri dei nostri clienti: beh, questa è esattamente la natura dell’essere professionisti, o mi sbaglio?”
Il cliente più affezionato dello studio è stato probabilmente Galt Toys, azienda di giocattoli per cui Garland cominciò a progettare la comunicazione e finì per progettare i giocattoli stessi, per vent’anni. “Per ogni gioco producevamo prototipi che erano i bambini stessi a testare. Poi facevamo modifiche in base ai loro commenti […] I bambini ci aiutavano anche a decidere le regole. Ricordo che dopo aver provato un gioco ci accorgemmo che c’era una possibilità che le partite finissero in parità. Chiesi ai bambini chi avrebbe dovuto essere il vincitore in quel caso. Uno di loro rispose: ‘Il più piccolo!’. Naturalmente il più piccolo del gruppo era lui. Inserimmo la regola nel manuale d’istruzioni. È ancora lì.”
Fra un lavoro e un altro, First Things First tornò a galla nel 1994, quando un articolo sulla rivista Eye evidenziò come, dopo trent’anni, il manifesto rappresentasse ancora un punto di vista radicale sulla funzione sociale della grafica. L’autore, il designer Andrew Howard, continuava però criticando un punto del manifesto, quello in cui Garland ammetteva: “Non vogliamo l’abolizione della pubblicità di massa rivolta al consumatore: non sarebbe plausibile”. Questo passaggio, per Howard, annacquava il manifesto, riducendo il suo messaggio a una lista di proscrizione per prodotti ‘cattivi’ anziché spingerlo a una critica a tutto campo del consumismo.
L’articolo di Howard segnò un forte e prolungato ritorno d’interesse per le tesi di Garland. Nel 1999, su suggerimento di Tibor Kalman, designer americano ed ex redattore di COLORS Magazine, la rivista di controcultura canadese Adbusters aggiornò e rilanciò First Things First: nella nuova versione, redatta insieme al critico Rick Poynor, veniva aggiornata la lista dei prodotti “stolti” – biscotti per cani, diamanti, birra light – che distraggono i designer da più nobili compiti come le campagne di marketing sociale, le cause pro bono e i progetti di information design.
Il succo non cambiava e il manifesto raccolse l’adesione di un gruppo di trentatré affermati professionisti del design, tra cui il creatore del logo I Love NY Milton Glaser, il tipografo svizzero Eden Spiekermann, Steven Heller e Ken Garland stesso, che accettò di firmare anche se non prese parte alla stesura del nuovo testo. First Things First 2000 fu presentato al Royal College of Arts di Londra, ripubblicato in sei affermate riviste di design e firmato online da migliaia di designer, alcuni dei quali ringraziarono pubblicamente Adbusters per averli spinti a fare di più e meglio.
Anche le critiche non tardarono ad arrivare. Il grafico americano Michael Bierut notò che nessuno tra i firmatari aveva mai lavorato su progetti commerciali e dunque il manifesto aveva lo stesso valore di “un voto di castità espresso da un gruppo di eunuchi”. Una compagine di designer inglesi colse la palla al balzo per scrivere una ‘Chiamata alle armi contro tutti i futuri retro-manifesti per disillusi’, il cui punto principale era che nessuna mostra per intellettuali o rivista di nicchia sarebbe mai riuscita a confutare l’ineluttabile verità: il design e la comunicazione sono parte integrante del capitalismo.
Quando, camminando per le vie di Barcellona, chiesi a Garland cosa ne pensava di First Things First 2000, mi confessò: “L’intenzione era buona. Penso che si avvicini un po’ troppo a quello che avevo detto tanti anni prima, forse avrebbero dovuto scrivere qualcosa di leggermente diverso, ma non voglio fare polemica. Ben fatto, ragazzi”. Qualche ora dopo, seduti nella sala conferenze dell’agenzia Villar Rosas, presentai Garland a un centinaio di studenti e appassionati di grafica che erano venuti ad ascoltarlo e gli posi la prima di una decina di domande che avevo preparato come moderatore del suo intervento.
Quel signore dagli occhi arzilli ignorò completamente il mio quesito. Si alzò e cominciò a declamare a gran voce un nuovo manifesto, che aveva scritto sul volo tra Londra e Barcellona. S’intitolava Last Things Last, che letteralmente significa “le ultime cose per ultime” ma che potrebbe essere tradotto anche come una sorta di augurio: “le ultime cose durano”. Garland specificò in effetti che si trattava delle sue ultime parole sull’argomento, dato che parlare del manifesto a distanza di quasi cinquant’anni lo annoiava tremendamente.
In poco più di due pagine scritte a mano, su un quaderno a righe, Garland dichiarava che il conflitto tra creativi e uomini di business era una bufala: lui stesso non avrebbe potuto realizzare nulla di tutto ciò che aveva fatto senza il supporto e il contributo creativo dei suoi clienti. Aggiunse: “Quando il futuro socialista che ho sempre sognato finalmente arriverà, ci saranno ancora beni e servizi da promuovere e vendere”. Quando si sedette di nuovo, mi lasciò ammutolito, con tra le mani una lista di domande che non aveva più senso porgergli. Anche la maggior parte della platea rimase impietrita. Per fortuna qualcuno azzardò qualche domanda e io me la cavai, malamente.
Da quel giorno di primavera del 2012 io e Ken Garland siamo rimasti in contatto. Un giorno sono andato a trovarlo nella sua casa di Londra, dove sua moglie Wanda, pittrice e donna straordinaria, mi ha cucinato un gazpacho alla polacca e Ken mi ha mostrato il suo studio, da cui è ufficialmente andato in pensione nel 2010. Qualche mese fa gli ho scritto di nuovo, per sapere come andava. Mi ha risposto che, per essere una vecchia scoreggia ottantenne, se la passava bene. Era felice della vittoria di Corbyn alle primarie del Labour e deluso dai risvolti presi dalle rivoluzioni arabe in Libia e in Siria: “Sono ancora un animale politico. Sono un socialista e penso che siamo così lontani dal socialismo come lo eravamo nel 1964”.
Gli ho chiesto se gli era giunta voce che un designer americano di nome Cole Peters aveva pubblicato online First Things First 2014, una nuova versione del suo manifesto adattata a clienti, tecnologie e professioni contemporanee. Non ne era stupito: “Nel 1964, quando l’ho pubblicato, le multinazionali stavano solo cominciando a scaldarsi i muscoli per estendere il loro raggio d’azione in tutto il mondo. Solo oggi ne vediamo i risultati. Non voglio dire che quel manifesto fosse una profezia del presente, ma senza dubbio è ancora attuale”.
Siamo andati avanti a chiacchierare di design e di nuovi media, di Occupy e della consapevolezza mediatica mostrata dai protagonisti delle ultime proteste che hanno scosso il pianeta. Prima di congedarmi, ci ha tenuto a fare una precisazione su First Things First. “È solo un dettaglio, ma alcune delle cose contro cui mi sono scagliato nel manifesto non avevano niente di sbagliato. Cosa c’è di male nel cibo per gatti, per esempio? È il primo prodotto che menziono, ma i gatti hanno bisogno di cibo! Che abbiano bisogno di così tanta pubblicità, invece, beh, quella è tutta un’altra storia”.