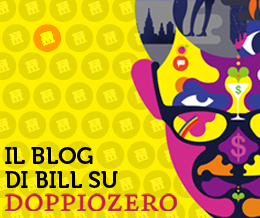Questa rivista è dedicata a William "Bill" Bernbach.
La sua visione della pubblicità - civile, mai banale, basata sulla verità - appare sempre più attuale.
Benvenuti e buona visione.
Su BIll 14 trovate, tra le tantissime altre cose, un’intervista fiume a Pasquale Barbella. Uno dei più grandi copywriter italiani, per cominciare. Ma anche un testimone sensibile di trasformazioni che, come sempre con la pubblicità, riguardano tutti noi. Qui potete leggere un estratto. Il resto vi aspetta sulla bella carta stampata del magazine.
Parleremo della tua storia ma anche di quella della pubblicità italiana. Anche perché nelle scuole professionali si fanno tanti esercizi ma non si tratta mai la storia di questo nostro mestiere.
Che è ignoto, non riconosciuto e non interessante per nessuno. Qualche volta neanche per chi lo fa. D’altra parte sono tanti i mestieri che sfuggono all’interesse generale. Adesso vanno di moda i cuochi, ma se un astrofisico vince il Nobel l’opinione pubblica non è così pronta a eccitarsi. Siamo in pochi ad aver capito che se approfondisci i meccanismi retorici della comunicazione commerciale e la loro evoluzione, hai uno strumento formidabile per smascherare i trucchi della propaganda politica, per esempio.
Però almeno nelle scuole di pubblicità, un po’ di storia…
Io ho cercato di farlo. Ho insegnato fino a due anni fa la pubblicità non solo per se stessa, ma anche per raccontare chi siamo e come cambiamo, trattandola come documento della cosiddetta pop culture – di cui è la manifestazione più vistosa. Ho cercato di ancorare l’evoluzione storica dei linguaggi al presente. Anche perché, se vai a caccia di insight, devi tuffarti nel reale, altrimenti ti attacchi agli asini che volano.
Il fatto è che non avere storia vuol dire non avere un ruolo.
La storia è sottovalutata sempre di più. Si fa fatica a percepirla come elemento strutturale del presente e del futuro. Prendi uno dei temi che ti stanno più a cuore, la rivoluzione di Bernbach. Se ne parla in tutte le scuole di pubblicità, ma chi ascolta tende a considerarla roba vecchia. Persino molti dei professionisti più maturi hanno, nei confronti delle radici, lo stesso atteggiamento. Bill è stato il più amato, il più ammirato, ma anche il più tradito dei maestri.
Intorno a Bernbach c’è una grande mistificazione.
Perché c’è una lettura referenziale del suo lavoro. Ok, ha fatto quegli annunci, Think small, bella roba, però non si è capaci di partire di lì e immaginare che dentro ci sia una visione del mondo, non si capisce il nesso tra quei lavori e la realtà, non ci si pone neanche il problema di andare a vedere com’erano gli annunci della concorrenza al tempo. Del resto, il principale difetto della pubblicità italiana è proprio la sua totale decontestualizzazione. Dalla storia e dall’attualità.
Com’è stato il tuo primo giorno in pubblicità?
Uno dei peggiori della mia vita. Io venivo da esperienze severe, ero abituato alla disciplina. Avevo gestito un magazzino. Ero stato istitutore in un collegio militare di orfani di guerra. E poi avevo timbrato il cartellino per quattro anni e mezzo alla Mondadori, dove era normale lavorare senza pause e rispettare gli orari. La mia prima agenzia, Colman Prentis and Varley (CPV), era la più grande d’Italia. Stava in un palazzo di Piazza degli Affari, a Milano, autorevole quasi quanto la sede della Borsa lì accanto. Quel giorno, ligio agli orari com’ero, arrivo alle nove in punto e trovo il deserto assoluto. Nessuno. Mi dico vabbè, sarà presto. Aspetto. Nove e un quarto. Nessuno. Nove e mezza. Nessuno. Comincio ad agitarmi. Sarà festa e non lo so? Mi stanno facendo uno scherzo? Capisci, per me il lavoro era sacro, è quella cosa che ti dà il pane…
E quindi continui ad aspettare.
Vedo vagare qualche ombra solo dopo le dieci. Non so quale sia la mia stanza, dove andare a sedermi, cosa fare. Il mio capo, una donna, arriva alle undici. Mi porta nel suo ufficio con due scrivanie e mi fa: “Questo è il mio posto e quello è il tuo”, poi comincia a truccarsi davanti alla macchina per scrivere mentre mi dà istruzioni. “Stai seduto lì, non pensare di scrivere, ti tolgo le penne: per sei mesi devi solo ascoltare attentamente e non rompere il cazzo”. È nervosa. Arrivano gli account. Con deferenza servile, si avvicinano per chiedere a che punto è il lavoro. Lei li tratta come degli stracci, dei rompicoglioni. “Stai scherzando? Per fare un lavoro serio ci vuole almeno un mese. Dal briefing sono passati solo quindici giorni”. E io lì, zitto, con le mani in mano, a chiedermi dove son finito. Questa solfa va avanti per un po’, prima delle undici non l’ho mai vista arrivare. Però ogni volta che ha il ciclo sparisce per tre, quattro giorni. Allora gli account mi guardano desolati. “Di’ un po’, te la sentiresti di scrivere quattro righe di body-copy?” Ero alle prime armi, ma avevo quasi tre anni di scuola Campari alle spalle, non ero proprio nelle nuvole. Una body-copy non si nega a nessuno, e io ero felice di accontentarli. In pochi minuti il testo era servito, e loro mi guardavano come Bernadette guarda la Madonna di Lourdes. Mi sono salvato grazie alle mestruazioni del mio direttore creativo.
Salvato?
Sì, perché l’agenzia, che non andava bene, di lì a poco fu commissariata dalla casa madre londinese. Jimmy Teale, britannico tostissimo, prese in mano le redini e impiegò tre mesi per capire chi doveva licenziare. Non solo i lavativi, ma anche i bravi superflui. C’erano sprechi enormi. Il numero dei condannati era già stato stabilito: cinquanta, metà dei quali dirigenti. Seppi poi che gli account mi avevano salvato da licenziamento sicuro: producevo poco, ma non per colpa mia, e avrei potuto dare molto di più dopo la riorganizzazione interna.
Così hai imparato che dovevi avere un buon rapporto con gli account.
Ah, ah! Beh, devo dire che ce n’erano anche di ottima qualità.
E il tuo capo? Personaggio interessante.
La adoravo. Era un’ex giornalista de L’Unità ed era stata corrispondente di guerra durante l’insurrezione algerina. Un’autentica pasionaria. Era ebrea, aveva perso il padre nel lager di Mauthausen, ma parteggiava per i palestinesi quando scoppiò la guerra dei sei giorni. Poi aveva mollato L’Unità perché troppo di destra, a suo dire. Mi insegnò poco della pubblicità, ma moltissimo della vita. E della politica. Era tra i pionieri più agguerriti della contestazione pre-Sessantotto e militava attivamente in uno dei primi gruppuscoli extraparlamentari.
Un clima che si respirava anche in agenzia?
Tantissimo! C’erano marxisti-leninisti, filocinesi, trotzkisti, anarchici… Lei mi spiegava con rabbia i motivi delle tensioni in corso. Diceva di lavorare in pubblicità per distruggere il sistema dall’interno.
Tutto questo entrava nelle campagne?
Assolutamente no. Non c’era ancora una coscienza sociale del mestiere, non sapevamo niente neanche di Bernbach, anche se in America era già cominciato tutto. Non solo in Italia, ma in tutta Europa la rivoluzione di Bernbach arrivò con qualche anno di ritardo. Ti posso dire con esattezza quando arrivò da noi: nel ’69.
Ricordi il momento.
L’importatore “ufficiale” fu Luigi Montaini. Aveva lavorato alla DDB di New York, poi in quella di Düsseldorf. Tornò in Italia come direttore creativo della Troost, inviato dalla Germania, e fece il botto.
In quegli anni esiste già una comunità creativa?
Una coscienza professionale comune comincia a formarsi tra il ’71 e il ’72. Prima c’erano due tipi di comunità: quella dei graphic designer e quella dei creativi d’agenzia. I grafici avevano organizzato il primo modello associativo (l’Art Directors Club di Milano) e costituivano una compagine molto elitaria, che escludeva i colleghi (art director e copywriter) impegnati nella pubblicità del mass market. C’erano nomi importanti, Grignani, Iliprandi, ma non erano dei pubblicitari come li intendiamo noi, erano dei designer – talvolta bravissimi. Una seconda forma di gruppo, più aperta, fu invece quella che Montaini sollecitò al suo arrivo, quando fondò il Creative Circle: durò solo un anno ma creò fermento e mobilitazione. Un esperimento insolito fu promosso nel 1974 da una rivista, Pubblicità domani. Il suo direttore, Lillo Perri, sposò un’idea di Umberto Eco, probabilmente l’unico intellettuale italiano che ci abbia mai preso sul serio. In occasione del referendum sul divorzio, Eco aveva scritto un pezzo su L’Espresso con il quale sfidava i pubblicitari a mettercela tutta per sostenere la causa. Perri riunì tutti i creativi che poteva, esortandoli a tirar fuori delle idee. Nei reparti creativi di molte agenzie si scatenò una gara febbrile di volontariato. Specialmente nella CPV, dove costruimmo un kit di idee pro-divorzio, messe a disposizione di istituzioni, movimenti per i diritti civili, associazioni etc.
Di cosa si trattava?
Erano idee in bozza che i gruppi impegnati nel “sì al divorzio” potevano finalizzare in proprio e utilizzare liberamente. Fu probabilmente la prova più riuscita di connubio tra pubblicità e contesto, quello che vai cercando anche tu con Bill. Considero gli anni settanta quelli di maggiore compenetrazione tra pubblicità e paese. Non a caso è stato il decennio in cui il testo ha avuto una funzione più importante dell’immagine. Si scrivevano testi più pensati e più arguti, e quella era già una rivoluzione. Il Sessantotto, in fondo, si può leggere anche come “sopravvento della parola sull’immagine”: non si smetteva mai di discutere, la contestazione verbale fu non meno debordante dell’uso del piombo, con quei sit-in che non finivano mai, le occupazioni studentesche e di fabbrica, le riunioni di movimento o di quartiere che si prolungavano fino alle ore piccole. Solo che io ero già vecchio. Avevo quasi trent’anni. I meeting li odiavo già allora, anche in agenzia, perché erano una gran perdita di tempo. Avevo già sposato la causa dell’One minute manager: meglio una decisione sbagliata subito che una giusta fra un anno.
(…)
Ma in mezzo a tanta politica c’erano sensi di colpa nel pubblicitario?
Tutto il contrario. Ecco un bel paradosso. I copy e gli art della mia generazione erano in gran parte schierati a sinistra. Sin dal famoso primo giorno che ti ho descritto, e in tutti i miei primi tempi in CPV, sui tavoli spiccavano Esquire e Playboy ma anche il libretto rosso di Mao, i proclami di protesta, gli opuscoli con le massime di Che Guevara (“dieci, cento, mille Vietnam”…) Tanti giovani erano di sinistra e la sinistra di allora non aveva pregiudizi sulla pubblicità. Era facile che ti invitassero alla Festa dell’Unità a raccontare il tuo mestiere e ad ascoltare i tuoi suggerimenti su come progettare una propaganda più efficace.
Di Berlusconi non c’era ancora traccia.
Quella è una cesura di molto successiva. Berlusconi ha praticamente trasformato la politica in pubblicità. Prima, a sputarci addosso era un mondo di destra (pagherei per tornare a quella condizione, era di gran lunga preferibile a quanto è successo dopo). Guarda che buffo, mi ci fai pensare adesso: avevamo molti più critici a destra o fra i benpensanti più compassati, che a sinistra, dove siamo sempre stati benvoluti. Oggi no, ma allora…
…c’era anche l’idea di poter utilizzare questo tipo di strumenti.
Ma anche nell’Art Directors Club Italiano, nato nell’85, cioè già in epoca sospetta, se vai a vedere trovi che i lavori più premiati nei primi anni sono sempre stati per il Manifesto, L’Unità, il PCI. A sinistra si credeva di più nella comunicazione brillante.
(…)
Cambiamo decennio: gli anni ottanta.
La cosa buffa è che i decenni hanno facce diverse fino agli anni ottanta. Di lì in poi tutto diventa un pastone indistinguibile. I novanta e i duemila sembrano delle repliche, senza un volto specifico, o forse sono io che non riesco a metterlo a fuoco. Mentre prima potevi dire: questo è anni trenta, questo è anni quaranta, questo è anni cinquanta… La moda cambiava in modo vistoso da una decade all’altra: gli anni dieci, gli anni ruggenti, le guerre che segnano…
E che faccia avevano gli ottanta?
La faccia di Reagan, di Thatcher, di Berlusconi, dell’ultraliberismo, facce che teoricamente dovrebbero essere favorevoli a una pubblicità più evoluta e professionale. Facce di manager sulle copertine di Class, Capital, Gente Money, guarda anche solo i nomi delle testate. Comincia lì tutta questa celebrazione euforica della “managerialità” come stile di vita. Era anche il decennio in cui i media telefonavano ai pubblicitari per inchieste fasulle. Su qualunque fregnaccia, meglio se con un po’ di sesso sullo sfondo. Una volta, una di Panorama mi chiama per un’inchiesta su Attrazione fatale, il film di Adrian Lyne, appena uscito nelle sale. «Ha riscontrato anche lei il trend sul ritorno alla famiglia? Cosa ne pensa?», domanda la cronista al telefono. A me imbastire un bla-bla pseudosociologico su un thriller di mero intrattenimento sembrava ridicolo. Continuavo a ripetere: “Non vedo nessuna tendenza, è solo un film.” Alla fine, delusa da queste reazioni così poco utili alla tesi precotta della sua cover story, mi chiede sfacciatamente: “Lei ce l’ha un’amante?”. Da prendere a schiaffi, come fa Nanni Moretti in Palombella rossa alla trendista che lo incalza. Ecco, questo erano gli anni ottanta.
Ho il dubbio però che allora si sia persa un’occasione di rendere più credibile la figura del pubblicitario.
Si tende a pensarlo, ma era tutto basato sulla finzione. Visto che il dirigentismo, l’aziendalismo e soprattutto il successo erano diventati di culto, i pubblicitari fungevano da vetrina ideale per una società effervescente quanto farlocca e diventarono di moda. Ci chiamavano guru e ci dedicavano pagine di sciocchezze per compiacere i loro inserzionisti, ovvero i nostri committenti. Fu un fenomeno da circo. Il pubblicitario era la figura carismatica del peggio, della banalità vestita dalle griffe. Che cosa abbiamo perso? Non potevi certo sperare di spiegare a chi t’intervistava qualcosa che andasse un po’ più in là della sua inchiesta fasulla.
Fu proprio una moda giornalistica.
Qualcosa di buono c’era, per esempio le recensioni di Oreste Del Buono (scusa il gioco di parole) su L’Espresso, che commentava le campagne pubblicitarie. Il resto era deprimente. Ricordo un servizio su non so più quale testata, dedicato ai pubblicitari, dove ho visto ritratti di Pirella, Mignani, Annamaria Testa, il non plus ultra della serietà, sotto il titolo “Vieni avanti creativo”. Queste cose m’indignavano in un modo tale che a un certo punto ordinai alla mia segretaria di non passarmi più intervistatori.
È allora che cambia anche il modo di raccontare.
Sono gli anni della decostruzione dei linguaggi, con MTV e i videoclip. Addio al filo logico, al senso della storia, all’urgenza della parola come elemento chiave del discorso. Ciò ha avuto un’influenza considerevole sulla formazione delle nuove generazioni: abolizione del sillogismo, della consequenzialità, della coscienza storica, della memoria politica. E intanto il successo crescente del fantasy, che va da Indiana Jones ai videogame fino ad Harry Potter e al grande revival di Tolkien. Non interessano più la linearità degli eventi, la verosimiglianza, i riferimenti al reale. Un fenomeno esploso chiaramente negli anni ottanta, e potenziato all’infinito dall’industria degli effetti speciali. Ovviamente non tutto, del nuovo corso, è da buttare. I video musicali sono spesso divertenti, bizzarri, simpatici. Per Lemonsoda mi capitò di sperimentare uno dei primi spot italiani senza una logica lineare, solo immagini che si susseguono oniricamente, evocazioni. Niente effetti speciali, tutto dal vero. Erano scenografie surreali: se vedevi delle nuvole che giravano, era un rullo con le nuvole disegnate; se vedevi una modella in una bollicina, era una bollicina gigante con la modella dentro… una cosa alla Méliès. Gli anni ottanta erano anche questo. E credo che non siano mai finiti.
Dove li vedi?
Sotto il profilo sociologico e culturale gli anni ottanta sono ancora tra noi. Li vedi nelle riviste di gossip, nei reality, nei cinepanettoni, nella politica. “Il nuovo che avanza” è uno slogan di quegli anni. Nuovo cosa? Le cose nuove che si sono viste negli ultimi trent’anni sono la rivoluzione del web (niente da obiettare) e la globalizzazione – quest’ultima traboccante di effetti collaterali indesiderati. Non tutto ciò che è nuovo è anche utile alla collettività. Sono buone le “aziende ospedaliere”? Ecco un lascito degli anni ottanta. Sono buone le poste che diventano banche? Chiedilo alle moltitudini in coda per una raccomandata. È passata l’idea dell’Azienda Assoluta. Anche Renzi fa parte di quell’idea; non a caso è salito al vertice con una campagna basata sulla rottamazione del passato.
(…)
E il rapporto tra web e pubblicità oggi?
Una risorsa formidabile. Ti dà la possibilità che abbiamo sempre inseguito, quella di uscire dai confini della pubblicità. Perché in realtà che cosa è la buona pubblicità? È quella non autoreferenziale, quella che ha un insight, un legame con il mondo che la circonda, una connessione vera con qualcosa di più grande. Non è il paradiso di Lavazza o Banderas che parla con le galline. Una comunicazione one to one vuol dire che ti vengo a cercare o sei tu che vieni a cercare me: se non hai un insight come si deve vieni punito immediatamente. L’aspetto negativo, invece, riguarda non il mezzo ma chi se ne occupa: con il web è cresciuta una generazione di nerd iperspecializzati i quali ne hanno fatto una specie di religione. Se li senti parlare sembra che abbiano scoperto Buddah. Terribile.
Ma forse siamo già nella fase calante di questo integralismo…
Lo spero ardentemente per loro. Sono talmente assorbiti. Nel momento in cui hai per le mani lo strumento che ti può affrancare da ogni prigionia, diventi tu stesso così autoreferenziale da credere che chiunque non abbia dimestichezza con quel mezzo è un coglione. L’hanno detto persino di Umberto Eco: era un rimbambito perché una volta ha scritto che non gli va di smanettare. Embè?
A volte sembra che sia: o dentro o fuori.
Ma questo è Is. No, non può essere, non mi piace nessun fanatismo. I media non possono essere un’ideologia per il solo fatto di esistere.
Senti, com’è stato chiudere con la pubblicità?
Bellissimo.
Sentimenti?
Je ne regrette rien. Nessuna nostalgia, nessun rimpianto. Vedo che, con la massima tranquillità, periodicamente butto via i documenti. Ho ancora un po’ di tenerezza per le campagne stampa. Le passo allo scanner e butto via gli stamponi. Prima avevo il garage pieno di carte, conservavo tutto, persino lettere, comunicati interni… impressionante.
Molte persone che ora sono fuori dalla pubblicità mantengono un legame molto forte con quell’esperienza.
Il fatto che io stia parlando con te di pubblicità ne è la dimostrazione. Un legame c’è. Avrei potuto dire no, guarda, parliamo d’altro, l’argomento non mi interessa più. E tu l’avresti anche capito. Però, dal momento che mi piace storicizzare, sono contento che tu sia qui a farmi queste domande perché ristabiliscono una connessione con il mio passato. Cioè con me, con la mia identità, con qualcosa che è stato parte integrante della mia esistenza. Posso essere felice di essermene distaccato ma comunque la pubblicità è una parte di me, di quello che sono, della mia visione delle cose. Per me è stata un periscopio, mi ha dato modo di comprendere aspetti della realtà e dell’esistenza che mi sarebbero sfuggiti se avessi fatto un altro mestiere.