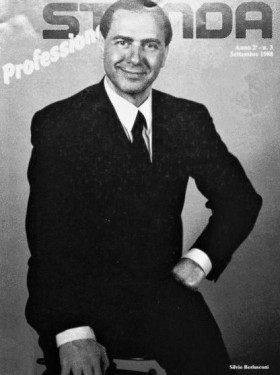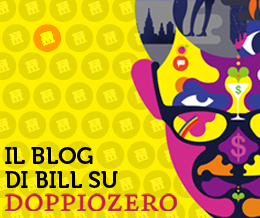Questa rivista è dedicata a William "Bill" Bernbach.
La sua visione della pubblicità - civile, mai banale, basata sulla verità - appare sempre più attuale.
Benvenuti e buona visione.
Bill 09 ospita una riflessione sul lungo trentennio di Berlusconi in pubblicità. Conseguenze, prospettive, responsabilità. Qui postiamo un estratto da un bellissimo articolo dedicato da Pasquale Barbella all’argomento. Il resto è su Bill 09.
“Il governo non è la soluzione del nostro problema, il governo è il problema”. Non è una battuta di Beppe Grillo ma del 40° presidente degli Stati Uniti, l’ex attore hollywoodiano Ronald Reagan, convinto sostenitore del primato del business sulla politica. Gran tagliatore di tasse e incentivatore del libero mercato, è unanimemente considerato – insieme a Margaret Thatcher – l’esponente ufficiale di una rinnovata visione del think big: quella che caratterizzò in modo profondo gli anni ottanta e i successivi, compresi i nostri. Volendo semplificare, è forse da lui (e dalla signora Thatcher) che bisogna partire per spiegare l’impatto e la persistenza di certi miti della nuova destra – liberismo sfrenato, concezione aziendale del servizio pubblico, radicalizzazione del marketing, spasmodica corsa al successo, individualismo, edonismo – emersi prima con la corrosione e poi con il crollo dell’impero sovietico e la fine della guerra fredda.
La storia è certamente più complessa di come la dipingono: più che essere determinata dai suoi protagonisti, li fabbrica al momento giusto. Condivido lo scetticismo di Tolstòj quando, in “Guerra e pace”, contestava le convenzioni della storiografia osservando che «vi sono leggi che dirigono gli avvenimenti, in parte sconosciute, in parte afferrabili da noi. La scoperta di queste leggi è possibile soltanto quando noi rinunziamo del tutto a ricercare le cause nella volontà di un uomo, appunto come scoprire le leggi del moto dei pianeti divenne possibile soltanto quando gli uomini rinunziarono all’idea dell’immobilità della terra.» Il Sessantotto si è guadagnato la S maiuscola per aver smascherato e combattuto ipocrisie, privilegi e secolari ingiustizie sociali. Si tende invece a sottovalutare la restaurazione iniziata negli anni Ottanta per un motivo molto semplice: il nuovo materialismo si presentava con uno scintillìo inedito, attraente, ludico, e non tutte le sue manifestazioni sembravano – almeno all’inizio – riconducibili a intenzioni diaboliche. Prendiamo, in Italia, la liberalizzazione e la proliferazione delle emittenti radiofoniche e televisive, per esempio. Il principio era bello; non così, o non sempre, le conseguenze. Anche l’enfasi sulla meritocrazia, propria di quegli anni, suonava bene – prima di essere smentita dai fatti.
Riepilogando: trent’anni fa l’Occidente si sposta a destra; i sindacati perdono peso; i poveri si preparano a diventare più poveri; la finanza si dà alla pazza gioia; la disco dance folleggia dappertutto; il cinema si dà agli effetti speciali; la televisione si impone a tutte le ore; la moda diventa un diktat; il profitto pure. Sboccia un nuovo star system, quello degli imprenditori e dei manager d’azienda. Nelle edicole italiane arrivano testate dal nome inequivocabile: Capital, Class, Gente Money. La pubblicità non solo si adegua, ma sforna nuove ed entusiastiche teorie: Jacques Séguéla allarga il diritto di divismo anche alle marche commerciali (che da noi assumono, per eufonia e fighettosità, il titolo angloamericano di “brand”). La profezia di Andy Warhol – «In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes» – si avvera su tutti i fronti: quello umano, grazie agli show televisivi che si vanno popolando di figure prese dalla strada (costano poco!) e, più tardi, all’attivismo collettivo nei social network; e quello degli oggetti, che la pop art aveva già promosso a icone culturali del nostro tempo. Non mancano, tuttavia, intellettuali che sorvegliano il nuovo corso con sguardo allarmato. Potentissima la metafora allestita da Bret Easton Ellis nel 1991 nel suo romanzo American Psycho: ritratto spietato dei giovani yuppie di Wall Street e dintorni, pieni di soldi e totalmente privi di scrupoli.
Lo psicopatico protagonista di American Psycho combina tali e tante nefandezze che al suo confronto un altro famoso criminale letterario e cinematografico, l’Alex di Arancia meccanica, sembra un boy scout. Eppure né in America né nel Regno Unito si sviluppano, a livello istituzionale, anomalie paragonabili a quella che ha imballato il nostro paese per decenni. Non che lì, beninteso, non si commettano orrori e soprusi ragguardevoli, spesso dalle conseguenze planetarie (le guerre dei Bush e l’avventurismo finanziario dei Lehman Brothers, tanto per servire le prime pietanze che mi vengono in mente): ma la vigilanza rimane più alta che da noi, e le istituzioni mantengono una certa saldezza. In Italia Berlusconi è stato il principale artefice (secondo la visione tolstojana il principale derivato) di una survoltata concezione del vivere, del sentire, del trasgredire. Film come il documentario Videocracy di Erik Gandini e Reality di Matteo Garrone raccontano con poetica esattezza l’interdipendenza fra trash televisivo, propaganda, marketing, politica e criminalità che ha generato lo smantellamento etico del paese e incurabili nevrosi di massa. Ma, essendo partiti da lontano, dobbiamo chiederci come mai fenomeni mediatici di estensione globale (spesso generati all’estero, come Il grande fratello e altri format tv di pari cinismo) abbiano prodotto in Italia guasti più significativi che altrove. Da morire di Gus Van Sant e The Truman Show di Peter Weir denunciavano la stessa sindrome da spazzatura di cui ci lamentiamo noi, ma di Berlusconi ce n’è stato uno solo, ed è toccato soltanto a noi. Perché?
A questa domanda le risposte più frequenti sono «perché ci ha saputo fare con la comunicazione» e «perché ha approfittato di una legittimità politica che doveva essergli negata a causa del conflitto di interessi». Se la prima risposta è giusta, la seconda lo è ancora di più. Quando, negli anni cinquanta del secolo scorso, i golpe in Sudamerica si susseguivano a ritmo di merengue, il primo atto dei dittatori era sempre lo stesso: occupare i media. Berlusconi li possedeva già, i media, e milioni di italiani lo hanno votato ugualmente, senza preoccuparsi dell’uso che ne avrebbe fatto. Il paradosso sta nel fatto che anche la maggior parte dei suoi detrattori si era nel frattempo impregnata di nuove essenze. Piaceva a molti l’idea di sentirsi – warholianamente – prossimi al firmamento. Berlusconi incarnava l’ideale del Grande Imprenditore e del Supermanager. Capace di rifondare i mass media, la morale e il paese con uno schiocco di dita.
Ma questo è il senno di poi. Drive In era, sì, volgare ma all’apparenza innocuo, come le goliardate, le farse e l’avanspettacolo di antica memoria. Certi veleni agiscono lentamente, e il mal di pancia arriva troppo tardi.
Con le cravatte di Marinella e il sorriso, i capelli trapiantati uno per uno e la voce da popstar, Berlusconi ha interpretato alla perfezione lo slogan più citato dell’ultimo trentennio, «Milano da bere». Marco Mignani lo aveva creato per l’amaro Ramazzotti, nel tentativo di rivitalizzare e attualizzare un prodotto che andava perdendo un colpo dopo l’altro. Con quel motto aveva ancorato la marca ai valori del “sano spirito imprenditoriale ambrosiano”, rilanciandola in un ambito di costume decisamente contemporaneo. Era una campagna fondata sulla nuova parola d’ordine, lifestyle. Un messaggio aspirazionale, secondo la neolingua che si stava propagando a macchia d’olio nelle sale riunioni del marketing e della pubblicità. Non che lo stile di vita, come concetto pubblicitario, fosse una gran novità. Che altro era il bel mondo disegnato da Dudovich, al tempo dei manifesti per Borsalino, per Martini, per i Magazzini Mele? Prodotti presentati come status symbol sono stati l’ossatura della pubblicità, in ogni tempo e paese. Ma il lifestyle degli anni ottanta, novanta e duemila è qualcosa di più. Non solo simbolo, non solo sogno, ma coazione al successo. Un successo alla portata di tutti, che si può comprare (o illudersi di comprare) anche senza particolari capacità, talenti, competenze.
Negli anni ottanta, gli istituti di ricerca applicata al marketing e alla pubblicità modellano e sviluppano classificazioni e indagini sulla popolazione più sofisticate che in passato. Alle rilevazioni di mercato e alle ricerche motivazionali si affiancano studi demografici più affilati, come le ricerche psicografiche. L’innovazione non è da poco: i cittadini, prima censiti per dati anagrafici, reddito, propensione e motivazione all’acquisto, sono ora assortiti in cluster psicologici e culturali che tengono conto di aspirazioni, orientamenti, opinioni, passioni, atteggiamenti, hobby, etc. Anche se i comparti così costruiti sono una dozzina, e svariano dalla controcultura più scazzata all’aspirazionismo più esaltato, gli inserzionisti italiani tendono a selezionare i loro target fra le due o tre categorie di status (reale o presunto) più elevato. La pubblicità si tuffa in una specie di “griffismo” di massa, benedetto dal culto estetico della fitness, della cosmesi, della moda. E del testimonial. Molto à la page, ma povero di idee, il marketing si lancia alla caccia implacabile non solo di calciatori, attori, attrici e cantanti, ma anche di illustri semi-sconosciuti pervenuti ai fatidici quindici minuti di celebrità attraverso i reality show.
La rivista Max pubblica ritratti di giovanotti a torso nudo prodotti con l’autoscatto. Se anche i ricchi piangono, come recitava il titolo della famosa telenovela messicana, ora si pretende – e talvolta si ottiene – che i poveri se la ridano felici, convinti come sono di poter sfondare nello show business come le veline o come il pescivendolo di Reality. Per i delusi non tutto è perduto: grazie al cielo ci sono il gratta-e-vinci e il superenalotto. L’Italia perde la bussola a velocità supersonica, affascinata dal nuovo che avanza anche quando nelle tasche e nel cuore non avanza niente di niente. Il berlusconismo premia i bocciati e, se carine ed eleganti, anche le bocciate. L’economia va sempre più in malora: molti negozi chiudono, ma si moltiplicano le palestre e i saloni di bellezza. La nuova destra decreta che si può accedere alla Camera e al Senato anche con un bel culo e un decente paio di cosce. La pubblicità si spoglia progressivamente di immaginazione ma, in compenso, prende il sopravvento sulla politica. La nuova euforia italiana sorpassa qualsiasi confine etico preesistente, spacciandolo per cascame veterocomunista. Evadere il fisco sarà pure un reato, ma chi se ne frega. Corrompere e lasciarsi corrompere è una liberazione, dopo la tristezza monacale di Tangentopoli. In pubblicità ridurre il corpo della donna a pura decorazione si faceva anche prima, ma adesso è quasi “doveroso” dopo le scoccianti prese di coscienza “comuniste” degli anni settanta. Berlusconi detesta la malinconia dell’austerità e della correttezza; sforna promesse che eccitano il buonumore, così come le barzellette – spesso imbarazzanti – che adora raccontare. (…)
Il resto è su Bill 09
Tag: Advertising, Arcore, berlusconi, bill 09, comunicazione, società, televisione