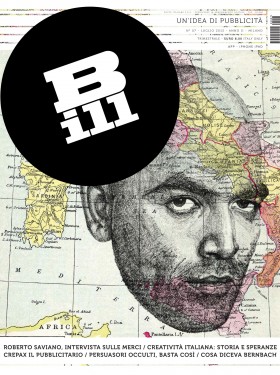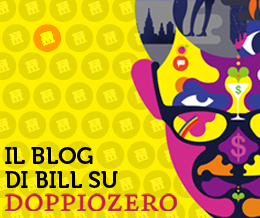Questa rivista è dedicata a William "Bill" Bernbach.
La sua visione della pubblicità - civile, mai banale, basata sulla verità - appare sempre più attuale.
Benvenuti e buona visione.
A Bill, ogni volta che si parlava dell’Italia ci dicevamo: “bisognerebbe intervistare Roberto Saviano sulle merci”. Beh, eccoci.
Qui l’intervista. Il resto – e non è un resto da poco – è su Bill 07.
Le merci ci sono sempre sembrate il tema dominante di Roberto Saviano. E poi è proprio dalle merci che nasce il linguaggio pubblicitario, e uno sguardo più vero sulla comunicazione italiana va cercato anche così. Il suo nuovo libro “Zero Zero Zero” tratta di un ennesimo prodotto di consumo: la cocaina. Merce debordiana per eccellenza, che contiene in sé anche lo spettacolo. Parliamone.
Hai cercato la verità sulle merci fin dal racconto sul porto di Napoli che apre “Gomorra”. Oggi sei arrivato alla merce contemporanea per eccellenza: la cocaina. È un tema che ti eri prefisso fin dall’inizio? O ti ha attirato man mano?
Mi ha attirato man mano, mentre mi interessavo ai meccanismi del reale. La merce mi è sembrata innanzitutto un elemento di sintesi. Nella complessità del vivere, una lattina o una penna sono la sintesi di un percorso infinito, che è culturale, è chimico… il tutto, sintetizzato poi da un comun denominatore: ISO. Ossia i container che le trasportano, quelli che tutti insieme sembrano mattoncini lego. Non c’è cosa al mondo che non stia lì dentro. Immagino che per molti il vero emblema della contemporaneità possa essere la pendrive, oppure il touchscreen. Per me è il container ISO, con il suo calcolo scientifico, con il suo massimo volume disponibile nel minor spazio. E’ così che la merce è diventata un mio strumento letterario.
Misurarsi con fenomeni di consumo così vasti vuol dire anche misurarsi con il loro consenso. E quando vedi che tanta gente desidera la stessa cosa, le tue prospettive cambiano. Quanto sono stati convinti, quanto la vogliono davvero?
È complesso. Forse non ho tanti strumenti per interpretare… io stesso non riesco a comprendere quanto sono condizionato o liberamente spinto a scegliere un prodotto.

E la cocaina?
In questo caso c’è un indicibile: la cocaina ti dà sensazioni meravigliose. Ti fa stare bene. Però il prezzo che paghi per quel benessere è immenso: impotenza, ischemie, nevrosi… persino il puzzo, perché le ghiandole iniziano a secernere in modo innaturale… ma quello che mi ha colpito della coca è che non ci arrivi perché senti il gusto del proibito degli anni settanta, il piacere che dava identità, come lo spinello tra amici.
Perché è una merce performativa.
Esatto. Stai bene e senti che non è niente di male. Non ti senti né tossico né fricchettone. Anzi, la prendi per migliorarti in un mondo che ti chiede proprio di essere migliore, cioè dormire poco, lavorare tanto… se per esempio decidi di lavorare di più ma poi sei depresso e malinconico, non stai rendendo. Persino sui cantieri, se il tuo capomastro ti vede sempre con la faccia appesa (triste, ndr) magari per il prossimo cantiere non ti chiama. Dunque la coca risponde anche a un bisogno di immagine, dimostrarsi tosti, resistenti… ed ecco l’esca. Ci viene chiesto un livello di performance non più umano. Le cellule non ce la possono fare. Manca una grammatica del riposo, dello svago, del desiderio… una grammatica che avrà anche mille sfaccettature, certo, ma non tali da mutare completamente la nostra struttura. È lì che arriva la voglia di coca.
…che corrisponde alla crescita obbligatoria del PIL.
Sempre di più, sempre di più… per questo la decrescita di Latouche può avere qualche significato rispetto al narcotraffico. Ed ecco perché per me la coca resta la merce delle merci: perché ne ha anche tutte le contraddizioni e tutti gli elementi attrattivi.
In effetti in “Zero Zero Zero” racconti che ogni altra merce può essere riempita di coca. Viene nascosta neisigari, nei giocattoli, nei pesci… persino dentro le statue della madonna. Come dire che ogni merce è eccitante e letale come la cocaina.
L’idea che ogni merce possa diventare contenitore di coca e che, peggio, a un certo punto possa essere un essere umano stesso, il cosiddetto mulo, a diventarne l’involucro, per me è la metafora decisiva… e forse ha ragione Deaglio scrivendo (sul Venerdì di Repubblica, ndr) che la mia riflessione sulla cocaina è persino marxista, nell’analisi della merce, del feticcio…
È un’altra definizione di questo tuo modo di pedinare la merce.
Però, anche se da Marx non si può prescindere, per me “seguire le merci” vuol dire Falcone. E’ Falcone che dice “segui il percorso dei soldi, guarda dove vengono staccati gli assegni, guarda dove attraccano le navi”… tutto il resto è importante ma secondario. Guarda dove spediscono le scarpe che producono, guarda il cemento che utilizzano. Insomma: segui la merce.
Con questo libro sembri dire a chi assume cocaina: “ecco qual è il suo vero significato”. In fondo “Zero Zero Zero” potrebbe anche essere definito un lavoro sul consumo responsabile…
(Ride)
Su Repubblica qualche mese fa scrivevi “Difficile ammettere che quando andiamo a fare la spesa rischiamo di finanziare le organizzazioni criminali. Eppure è così”. Stai cercando di responsabilizzare i cosiddetti consumatori a tutti livelli.
Proprio così, una sorta di consumo responsabile. Devo dire che ci sto pensando per la prima volta e mi ci ritrovo. Credo che molti consumatori saranno tentati dallo spulciare questo libro. Certo, confesso loro che alla fine resteranno un po’ disgustati all’idea di partecipare al traffico, più o meno lontanamente. Però, almeno sappiano cos’è. E non è soltanto il consumare coca, ma anche comprare nei loro supermercati o entrare nei loro ristoranti. Lì c’è semplicemente una diversa qualità di coscienza morale. Chiaro, entrando in un ristorante puoi anche non sapere, mentre invece quando compri coca è evidente. La differenza è tutta lì, nella quantità di responsabilità, di coscienza. Però è così.
Hai scritto di aver iniziato a “sviluppare un disprezzo per le cose” da quando sai “come vengono fatte, qual è la loro origine, come vanno a finire”. E oggi che rapporto hai con le merci?
Un po’ ossessivo. Senza però il tipico meccanismo morale del consumatore critico, cioè “non tocco la penna fatta dai bambini”. Io piuttosto voglio sapere tutto della penna che ho in mano. Per esempio, se è fatta in un Laogai (i campi di lavoro forzato in Cina, ndr). Per me è stato importantissimo incontrare Harry Wu – l’ho portato in tv, su La7 – il quale credo sia stato l’unico ad essere scappato da un Laogai. In questo momento il premio Nobel per la pace, Liu Xiaobo, è rinchiuso in uno di questi campi. Nel suo Laogai fanno prese elettriche esportate in tutto il mondo, anche lui le produce. Quelle tipiche, da un euro. Ecco cosa c’è dietro la merce.
La lingua delle merci è la pubblicità, e nel tuo libro si parla delle campagne di Natalia Paris, la modella colombiana che divenne compagna di un narcos. A volte quel tipo di pubblicità patinata e falsa sembra unasorta di estetica della corruzione.
È una fenomenologia. È come se addestrasse la vita alla possibilità della corruzione… e comunque, sarà banale, ma da quando io sono noto vedo che c’è chi, alle cene, alle feste, se non si presenta con donne meravigliose su tacchi altissimi viene visto quasi come uno che non conta. E tutto questo arriva da quella pubblicità nella quale non hai valore se non sei in un certo modo. Lì inizia l’estetica della corruzione. E qui per corruzione intendo: inseguire standard che non sono nella tua persona per ottenere un’immagine che non è la tua.
Nel 2010 in “Vieni via con me” citi l’allora premier Berlusconi: forse il tuo conflitto con lui – con Il Venditore, come lo definì Giuseppe Fiori – diventa inevitabile proprio cercando la verità nelle merci, ancor più che per motivi politici.
Lì c’è stato un corto circuito: fin quando tu scrivi di mafia, come migliaia di altre persone, va bene… ma quando crei un allarme, un’attenzione condivisa, allora il Venditore inizia a entrare in allarme. Finché vendi, lui è sempre felice. La forza di Berlusconi è stata sempre comunicare “vai bene così, non credere a chi ti dice che devi migliorare… no, cura te stesso, sii felice facendo quello che ti conviene… non fa niente, lo fanno tutti, vivi!”. Quando invece arriva questo ragazzo pelato dal sud e inizia a vendere qualcosa che dice il contrario, cioè muoviti, capisci, studia… ecco, questa roba mette in tilt il Venditore. È come se ci fosse a fianco di ogni acquirente una voce che dice “guarda che questo prodotto ti costringerà a cambiare vita”. E il venditore ha avuto paura. Non tanto del tema, quanto del modo in cui si stava sviluppando presso il pubblico.

Racconti che ogni panetto di cocaina ha un logo, con il quale i narcos garantiscono sulla provenienza e la purezza. Spesso vengono usati logo già esistenti (dai Teletubbies o Hello Kitty fino a Puma, Nike, Lacoste). Questo dimostra che la coca è davvero sul punto di diventare una merce vera e propria. Siamo a un passo dalla legalizzazione che tu immagini.
Quando ho visto il logo che denota qualità e provenienza, ho pensato “ecco, è la merce delle merci. Esiste, è la più venduta ma tutti dobbiamo fingere che non esista”. Sai, fosse un mercato clandestino, come i dvd falsi… ma se diventa la merce più diffusa del mondo, o quantomeno quella che fa arricchire di più, a quel punto le cose cambiano. Quando da un chilo di coca guadagni duecentosettantamila euro, dimmi con quale chilo di quale cosa guadagno così. E con questa semplicità nel produrla: la pianta della coca ha solo bisogno di un clima tropicale, e oggi viene coltivata sul 5% delle terre su cui è possibile mettere la pianta… c’è ancora tutta l’Amazzonia, che infatti viene abbattuta, se ne fa legna e poi si pianta la coca. Mi sento di dire che il logo è l’immagine principale che dimostra quanto quello della cocaina non sia un mercato clandestino ma semplicemente un mercato ufficioso.
È come se fosse la merce universale, quindi può avere tutti i marchi.
È proprio così.
Nei tuoi libri parli dei brand chiamandoli per nome, come fa Bret Easton Ellis. Il boss indossa la tuta di Abercrombie, veste Versace, viaggia su una Smart… non scrivi “su una city car”, scrivi “su una Smart”. Così ottieni un maggiore realismo narrativo. Che importanza hanno i marchi nella tua poetica?
Lo faccio per mostrare la quotidianità di quello che sto raccontando. È la mia strategia letteraria. Se io ti dico che un boss è su un’auto giallo fosforescente, tu vedi la suburra, la cafoneria… ma se ti dico “una Smart gialla”, magari pensi: è quella che ha la mia fidanzata! Allora inizi a sentire la vicinanza. Ecco perché il marchio, questa presenza costante nella vita quotidiana, diventa quanto di letterariamente più forte io possa usare per avvicinare una storia spesso stravagante al lettore che ha una vita spesso ordinaria. Questo riguarda anche i vestiti. Per dirne una, il clan di Lauro, per tutto il periodo della faida, ai processi indossava solo le Paciotti. Perché per loro era il simbolo della massima eleganza, e allo stesso tempo di comodità.
Strani testimonial…
Quasi dei testimonial, sì. Diciamo che oggi nessuno ha il coraggio di usarli, perché mi rendo conto che sarebbe come sfruttare il male, però, quando vanno ai processi, tutti i narcos hanno sempre vestiti italiani. Tutti. Non è solo per essere eleganti o per sembrare un manager di un’azienda importante. E’ qualcosa di più. È mostrare a tutti che non si è delle belve. È un modo per dire “state giudicando dei vostri pari”. Cioè voi usate le manette perché non riuscite a fermarci sul piano economico, che è poi la linea difensiva dei casalesi e dei corleonesi. Non a caso sono le uniche due organizzazioni ad aver preso il nome dai loro paesi. Corleonesi da Corleone e casalesi da Casal di Principe. La loro linea difensiva è: noi siamo degli imprenditori, gli omicidi sono parte della nostra cultura, le nostre famiglie quando si scontrano è per business. Pagheremo, ma restiamo imprenditori, contro i quali lo stato inventa l’accusa associativa di mafia o camorra, perché non riesce a fermare la nostra capacità d’impresa.
Quindi l’uso dei marchi è funzionale…
Infatti. Vuol dire “io sono una persona elegante, per bene, come potete immaginare che una persona così sia in coerenza con le vostre accuse?”
Cioè i brand costruiscono realtà. Tu li citi per essere più realistico, i boss li usano per sembrare più credibili.
Certo.
Hai mai avuto problemi con i marchi che citi?
Solo con Mozzarelle Mandara, il cui proprietario è stato scagionato dall’accusa di aver rapporti con la criminalità organizzata, notizia che mi fu chiesto di riportare. Tutti gli altri no, perché io mi limito a citare le inchieste. I grandi marchi in difficoltà però sono all’attenzione delle mafie di mezzo mondo, che non vedono l’ora. Non dico in questo periodo, ma proprio in queste ore. Perché un marchio che ha una storia permette loro di poter versare tanti soldi, invece di fare interventi di minor portata per non dare nell’occhio. Per esempio, molti marchi con nomi inglesi sono della Camorra. Potrebbero avere molto più denaro, ma devono fermarsi, perché altrimenti la percezione immediata è che si tratti di un’azienda dopata. Quando invece si tratta di un marchio importante puoi permetterti di aprire subito punti vendita, sono attività coerenti con la sua storia. E il marchio elegante non fa sentire il puzzo di riciclaggio…
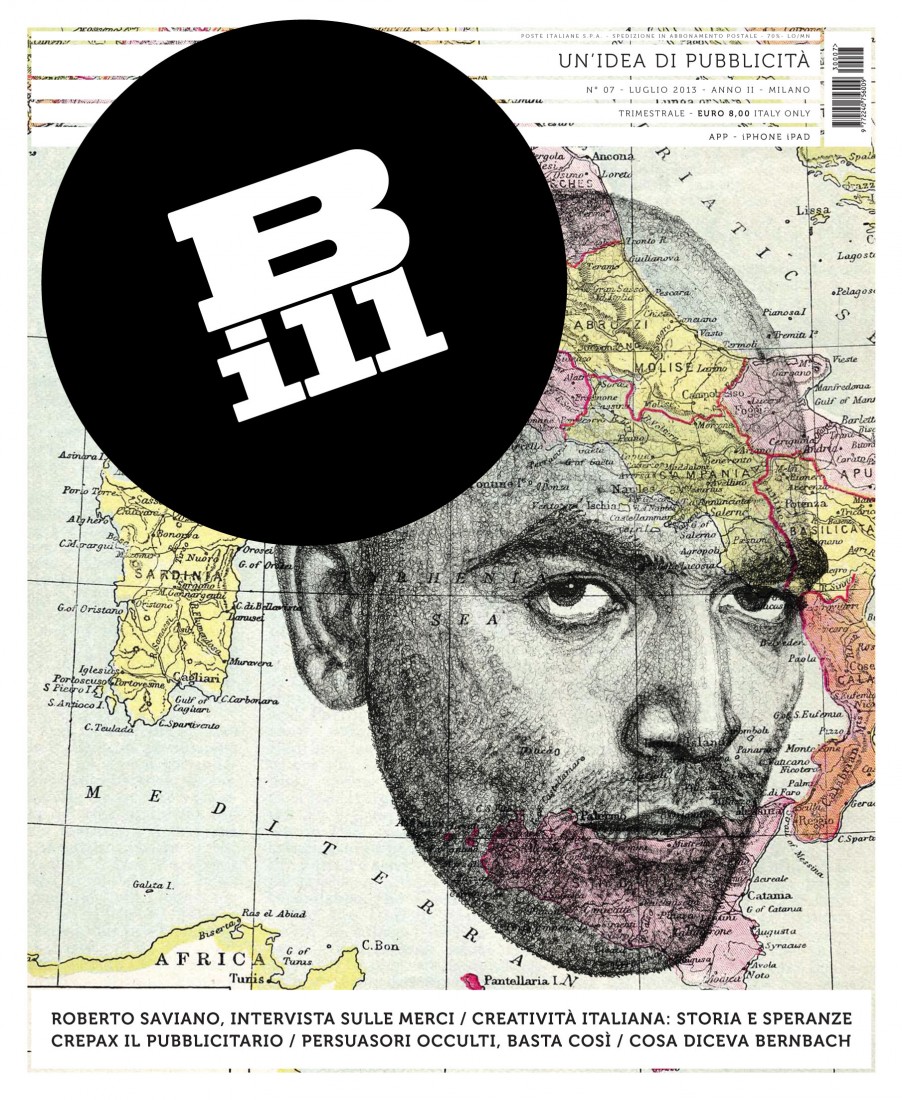
La merce per eccellenza del Novecento è la Coca Cola. Come suggerisce il nome, è anche a base di foglie di coca (ma va precisato che già dagli inizi del secolo scorso vengono “de-cocainizzate”). La bevanda nacque a fine ‘800 come coadiuvante fisico, utile a “performare”. Un altro prodotto della modernità. Cioè un antidoto per resisterle.
È una cosa che avrei dovuto inserire nel libro. Non le ho dedicato una riflessione solo perché ero più attento al meccanismo del narcotraffico, ma è una storia veramente interessante da affrontare … e c’è anche un’altra cosa: quando la Coca Cola viene contestata perché c’era la cocaina, viene anche attaccata a proposito del farla bere ai bambini. Allora ricorrono a un vecchio signore che fa regali ai piccoli: Santa Claus, ovvero Babbo Natale, il quale nella sua forma moderna è un’invenzione di Coca Cola, tanto che il bianco e il rosso del suo vestito vengono dai color del marchio… Babbo Natale beve la Coca Cola, e i bambini intorno a lui aspettano che finisca di bere per prendere i regali.
C’è un saggio di Nicola La Gioia sul tema.
Certo. È bellissimo.
Senti, vedendo il tuo nome sulla copertina si direbbe che…
…sembra la Coca Cola! (ride)
No, no… ma quasi. Sembra che il tuo cognome oggi sia un marchio.
Ah. Forse lo è.
Quindi Saviano è un brand? È un’idea che accetti?
Non mi repelle. Non se identifica un determinato tipo di storie scritte in un determinato modo. Per provocazione direi che se è come il brand Kapuscinsky (grande reporter polacco, ndr), il quale per me significa tutta una serie di cose, ci sto.
In certi passaggi di “Gomorra” sembra chiaro quanto tu, allora, riponessi grandi speranze nei media: “Le griffe della moda italiana hanno cominciato a protestare contro il grande mercato del falso gestito dai cartelli dei secondiglianesi soltanto dopo che l’Antimafia ha scoperto l’intero meccanismo. Prima di allora non avevano progettato una campagna pubblicitaria contro i clan, non avevano mai fatto denunce, né avevano informato la stampa rivelando i meccanismi di produzione parallela che subivano (…)”. Le tue aspettative sono cambiate?
Ho conosciuto meglio i mass media e sono rimasto molto deluso. Però continuo ad avere fiducia nella possibilità di trovare spazi importanti dentro le contraddizioni. Per intenderci, io sono convinto che in questo il lettore ha un potere immenso. Se una persona decide di dedicare il suo tempo ad approfondire, leggere riviste, prendere libri, guardare documentari, cambiare idea anche mille volte, ascoltare fonti che prima credeva attendibili e poi si accorge che non lo sono più… ecco tutto questo sono certo possa mutare l’attenzione dei media. Io ne sono la prova vivente. Queste storie che racconto non sono sconosciute. Sono tutte già battute dalle agenzie giornalistiche, già entrate nelle inchieste giudiziarie: le ho scelte apposta. Perché prendere storie note, mai seguite fino in fondo e mai messe insieme, secondo me restituisce la vera forza del lettore: la possibilità di decidere che “di questo mi voglio occupare”. E allora ne discuti a cena, ne parli nei blog… tutto questo secondo me può produrre cambiamento. D’altra parte l’esperienza della primavera araba è questa: ragazzi che nella loro quotidianità, utilizzando lo stesso facebook con il quale un attimo prima rimorchiavano o facevano gli auguri di compleanno, iniziano a discutere di come cambiare il paese. Cioè qualcosa che prima veniva vissuto come una cosa morta, insopportabile, che invece improvvisamente si decide di approfondire, magari per sbagliare, tornare indietro, fare due passi avanti… insomma sono convinto che i media sono importanti se hanno utenti, lettori che decidono di trasformarne il percorso. Sono loro a dettare la linea editoriale. Non lo dico perché ho una visione metafisica della rete. Però credo nella possibilità vera, concreta… e da scrittore cerco in tutti i modi di sottoporre le mie storie al lettore perché le scelga.
Quindi tu lavori perché lui le senta sue.
Se non le sente sue, ho fallito. Per me creare empatia è il primo obiettivo professionale. Perciò sono così attento alla promozione. Non ho alcuna vergogna del promuovere il mio prodotto… mentre invece spesso il letterato…
Questo è un punto importante. Nella prefazione a “L’affaire Dreyfus” scrivi che Zola “comprende le potenzialità comunicative di ciò che sta accadendo: per la prima volta in Europa la carta stampata ha un peso dirompente nell’orientamento dell’opinione pubblica e per la prima volta gli intellettuali, uniti, si schierano in difesa dei diritti umani”. Cosa pensi del modo in cui oggi gli intellettuali usano i media?
Quelli italiani sono indietro anni luce. Vengono da una tradizione politica e culturale per la quale il promuovere è una schifezza. Se hai bisogno di promuovere le tue parole significa che le hai scritte per guadagnare, non sono scritte con il cuore, non vengono dall’anima. Soprattutto, sperano che il libro si venda nonostante la loro scarsa presenza. Sperano di apparire solo una volta in una televisione, solo un’intervista per poi sparire…
C’è anche un pensiero elitario in questo.
Senza dubbio sì. Se sono uno scrittore davvero importante devo essere invisibile o quantomeno fascinosamente in disparte. Io però penso ai grandi, penso a Victor Hugo o a Jack London, che all’epoca utilizzavano tutti i mezzi possibili per fare arrivare il loro messaggio. Mi rendo conto che nella strategia di comunicazione possono esserci errori. Può esserci disequilibrio, e magari invece del libro prevale il vettore che lo ospita, tv o radio che sia, oppure la strategia è troppo concentrata sulla tua persona e non sulle tue parole… Errori che io faccio. Continuamente. Ma è qualcosa che metto in conto. Sono disposto a errare piuttosto che avere un atteggiamento elitario.

I media generalisti conducono ad alcune narrazioni codificate. Per esempio, dopo la denuncia devi sempre dare il famoso “segnale di speranza”…
…che qui non c’è!
Esatto. In “Zero Zero Zero” mi pare che manchi. Come lo hai detto ai media?
Mi sono mosso con un’onestà che può anche sembrare un po’ strategica. Cioè, io non ho speranze. Personalmente, intendo. Per la mia vita. Proprio non ho la speranza, non sono riuscito a uscire da questa mia situazione… però dò speranza a chi mi legge. Non posso assolutizzare la mia malinconia, che nasce dall’essermi rotolato in queste storie infami, nelle quali peraltro continuo a rotolarmi. Io dico che in realtà, se speranza c’è, viene da altri. Dentro di me non la trovo. È una colpa? Sì. Io mi sento per tutto il libro in colpa per questo motivo…
È la parte più dura del libro. Quella in cui non riesci a risolvere la tua situazione.
No. Io proprio non la riesco a risolvere. D’Orrico lo ha scritto, sul Corriere della Sera: “questo è il libro di uno che ha solo senso di colpa”. Lui mi suggerisce di scrivere fiction proprio per liberarmene. Io non ce la faccio. Soprattutto, credo nell’equilibrio che ho cercato di costruire in “Zero Zero Zero”, cioè informazione e riflessione, introspezione e poi di nuovo oggettività. Ho cercato la stessa strategia letteraria di Uwe Johnson, che nel suo “I giorni e gli anni” scrive giorno dopo giorno cosa c’è sul New York Times e quel che succede a una madre e una figlia. Quella sua cadenza tra il dato di cronaca, oggettivo, tecnico, a volte noioso, e la quotidianità, con il racconto letterario della famiglia, mi ha dato il senso della vita come raramente l’ho trovato, sulla pagina. Io sono un microbo rispetto a lui, ma ho tentato di costruire questa stessa alchimia. Anche nel mio libro il dato freddissimo, oggettivo, tecnico, è posto a fianco della mia reazione, spesso disgustata e nauseata.
Insomma, tu e la merce.
Io e la merce. Proprio così.
A questo proposito ho un’ultima citazione. Fabio Fazio, “Vieni via con me”, 15 novembre 2010: “Dopo la pubblicità, torna Roberto Saviano”. Anche lì c’è la merce e ci sei tu.
Sono diventato merce anch’io? In qualche misura sì. Sono diventato brand anch’io? In qualche misura sì. Sento che però questi sono involucri. Cioè sento di stare sul vettore ma di non esserne determinato fino in fondo. In cosa sento di non esserne determinato? Nel fatto che non c’è un solo secondo che mi venga richiesto, nelle mie interviste o nei miei monologhi. Nessuno mi dice “parla di” oppure “cerca di non parlare di” o “parla meglio di”. Mai. Mi sento libero. Poi c’è un’altra cosa. Ho avuto richieste di pubblicità legate ad aziende di occhiali, pantaloni, corn flakes… se non la faccio non è perché sia contrario alla pubblicità in sé. Anzi, la reputo pure una cosa interessante. Se io fossi un attore che non deve avere questo mio rapporto con le merci, se non dovessi narrare questi temi, se insomma il mio mestiere dovesse cambiare, la pubblicità la farei. Se però si dimostra che un mio giudizio può essere comprato, allora anche gli altri miei giudizi iniziano a saltare, quando tratto di narcotraffico o di mafia. Il pensiero di una mafia che ti riempie di soldi per non farti parlare di lei arriverebbe a molti. E poi non devo solo mantenere un ruolo simbolico e mediatico. Devo mantenerlo anche dentro di me. Per difendere le mie parole. Dunque, io cerco di tenere per me uno spazio di libertà all’interno della battaglia delle merci. Rendendomi conto che se rinunciassi al Saviano “dopo la pubblicità”, il mio messaggio, le mie storie, non arriverebbero a così tante persone. Per me è una mediazione continua, lo dico senza problemi. So che si può sbagliare, a volte ne soffro. Però cerco di restare nella contraddizione. E la contraddizione mi piace.
L’intervista finisce. Gli portano un po’ di copie del suo libro da firmare. Prima di andar via, gli mostriamo sul nostro pc “il ritorno di Ben Ali” di Memac Ogivly (ne abbiamo parlato su Bill 1), l’azione di live advertising premiata a Cannes, quella che tanto influì sulla partecipazione popolare alle prime elezioni libere in Tunisia. È il nostro piccolo “segnale di speranza” nella possibilità di usare il linguaggio pubblicitario in modo civile. “Dovrebbero trasmetterlo in prima serata”, osserva entusiasta.
Il resto è su Bill 07.
Tag: Advertising, Bill 07, cocaina, gomorra, italia, pubblicità, roberto saviano, zero zero zero